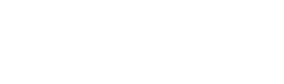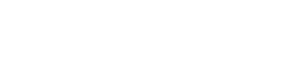Intervista rilasciata a Marco Parella, giornalista di ToroNews il 9/12/2017.
Le Loro storie, Alessandro Gazzi: “Da giovane non parlavo. Il calcio per ritrovare la gioia di un bambino”
Esclusiva / La Primavera della Lazio, poi tante squadre fino a ritrovare se stesso al Toro: “Con tutti i miei limiti”.
Un nuovo modo di raccontare il calcio: quello dei protagonisti. Calciatori, allenatori, dirigenti. Sempre sotto la luce dei riflettori, ma mai veramente compresi o comprensibili. Noi li vogliamo avvicinare ai tifosi e ribaltare il meccanismo delle interviste. Non saremo noi a chiedere, saranno loro a raccontarci un aspetto del mondo in cui vivono. Un tema libero, potremmo dire. Sono i protagonisti stessi della nostra passione a condividere con noi “Le Loro storie”. Senza filtri, senza meta.
Tanto introverso da rischiare di sembrare brusco, ma solo quando scrive. Parole poche davvero. In campo il cuore, alla sera il blog per aprirsi al mondo. Alessandro Gazzi è un caleidoscopio inesplorato di sfaccettature, un pigmeo che ce l’ha fatta in mezzo ai Watussi, un corpo estraneo (e una mente, soprattutto) nel mondo del calcio. Il racconto che fa del suo viaggio alla ricerca della gioia fanciullesca di tirare calci a un pallone è qualcosa che non rimane soltanto nelle parole scritte su una certa lavagna di Bari, ma travalica e attraversa le anime buone. Anche quelle che hanno dei limiti. O almeno lo pensano.
Spostamenti e traslochi per me sono molto stressanti. Negli ultimi due anni sono passato da Torino a Palermo e da Palermo ad Alessandria. L’ultimo trasferimento è stato duro perché io e la mia famiglia siamo rimasti in albergo fino al 20 settembre. Fortunatamente mia moglie e le mie tre bambine si sono sempre messe a disposizione del lavoro che faccio. Cambiano ambiente, casa, scuola, ma si adattano ogni volta al nuovo contesto e so quanto sia importante curare l’unione famigliare e avere qualcuno che ti sostenga e ti dia fiducia nei momenti difficili. Io cerco di farlo, nonostante i miei limiti.
Da giovane praticamente non parlavo, facevo fatica a tirare fuori due frasi intere, anche nello spogliatoio mi rivolgevo a pochi compagni, non ero per nulla estroverso. Con l’età e un profondo lavoro su me stesso un po’ sono migliorato, ma rimango comunque molto riservato, timido. Ho ancora un po’ di timore a stare al centro dell’attenzione. A Bari, l’anno dell’arrivo di Conte (2007/’08, ndr) c’era quella cavolo di lavagna. Lo staff ci scriveva sopra gli orari degli allenamenti e comunicazioni di servizio. Io iniziai, quasi per caso, a scriverci dei brevi commenti scherzosi. “Cercasi guanti per Vito” scrissi un giorno, in riferimento alla giornata no del nostro portiere. Qualcuno notò quella scritta piccola, un po’ defilata e rise. Divenne una tradizione. Quando facevamo il torneino tra di noi a metà settimana, mettevo le pagelle. “Bomber: voto 4, cieco perché non ha visto la porta”, tracciai col gesso quando un mio compagno sbagliò un gol facilissimo. Una domenica, durante la partita, vedemmo l’allenatore mandare un sms in panchina. Credo si messaggiasse con il tattico, ma da quell’episodio nacque un sondaggio: “Con chi si stava scrivendo il mister?”. Vennero fuori le risposte più assurde. “Il Dalai Lama”, scrisse qualcuno. Questo era il peso delle battute, cose leggere che facevano ridere tutti e nessuno si offendeva. La lavagna mi ha aiutato a interagire, è stato un espediente per far conoscere una parte del mio carattere che non sarebbe venuta fuori altrimenti.
Per me il calcio è stato un viaggio interiore alla ricerca di quello che volevo essere. In tutti questi anni non ho fatto altro che cercare le sensazioni genuine e spontanee che avevo quando ero un bambino. E, un po’ per caso, un po’ perché forse doveva andare così, quelle sensazioni le ho trovate a Torino la stagione in cui abbiamo giocato l’Europa League.
Ho iniziato giocando due anni nella Primavera della Lazio, poi sono tornato a Treviso, ma in quelle due stagioni avevo vissuto delle esperienze che mi avevano sfiduciato completamente. Sono stato a un passo dal mollare tutto a 19 anni. Invece ho ricominciato dalla C1 con la Viterbese e pian piano, stagione dopo stagione, squadra dopo squadra, ho ritrovato quelle emozioni che cercavo. Al Toro mi sono sentito il calciatore che volevo essere: un centrocampista non appariscente, che non ha eccellenze a livello tecnico, ma che si mette a disposizione dei compagni. È stato un viaggio lungo e per arrivare fin qui ho dovuto attraversare tempi ed esperienze non sempre positive, in contesti molto diversi tra loro; ho affrontato difficoltà che andavano al di là del campo da gioco… avete capito cosa intendo. Io ho considerato il calcio una ricerca della persona che volevo essere da piccolo.
A 8 o 9 anni avevo i sogni di tutti i bambini, ma durante l’adolescenza non ho mai pensato realmente di farcela a diventare un calciatore professionista, probabilmente perché sono fatto in un certo modo. Forse in fondo, proprio in fondo, un minimo di speranza c’era, ma ero abbastanza predisposto al fatto che la selezione naturale che avviene nel corso degli anni mi avrebbe tagliato fuori. Mio padre mi aveva avvertito: “Solo un bambino su 6.000 riesce a fare del calcio il suo lavoro”. Mi ero fatto due conti e avevo capito subito che sarebbe stato difficile. Conservando in me quella frase, ho vissuto la mia vita serenamente, senza paranoie. Andavo all’Itis con indirizzo informatico, pensavo di iscrivermi all’università per prendere la laurea in informatica. Non c’è mai stato un vero e proprio piano B. Studiare o lavorare, non so. Per questo, quando ho firmato il mio primo contratto da professionista avevo paura, sembrava fosse accaduto qualcosa che non avevo previsto.
Non vuol dire che prima io sia stato triste o che i dieci anni tra Treviso e Torino siano tutti da buttare. Però vivevo le emozioni in campo con meno intensità, consideravo il calcio come un semplice lavoro, nonostante la passione ci sia sempre stata. Il quadro definitivo di me stesso l’ho avuto poi solo al Toro in quell’anno magico.
In granata sentivo la fiducia. In quel periodo ho iniziato a lavorare dal punto di vista mentale sulla concentrazione, cosa che mi aiutato moltissimo su più livelli. È attraverso quel lavoro introspettivo che è nato il mio blog. Lì racconto brevi esperienze mie o sensazioni di campo, lo faccio d’impulso, senza ragionarci troppo. Non ho profili social e quel blog è nato come tentativo di mostrarmi al mondo.
Adesso, a 34 anni, sento che il mio viaggio nel calcio non è ancora finito, ma bisogna comunque prepararsi per il prossimo, di viaggio. Progetti ne ho tanti, avrei voglia di fare tante cose, dipende tutto dalle motivazioni e dagli stimoli. Ora però sono concentrato su quello che in uno, due o tre anni dovrò concludere. Poi valuterò con calma quale strada intraprendere. Ho sempre voluto essere me stesso, non assomigliare a nessun altro perché è difficile essere qualcosa di diverso da sé e avrebbe poco senso snaturarsi. Non posso essere un trequartista dai piedi buoni, la mia caratteristica è la grinta e, sinceramente, devo ancora riflettere sul perché ho sempre messo in campo questa peculiarità. Però da questo tratto di me è nata quella scivolata contro il Genoa (nell’incredibile rimonta nei minuti di recupero firmata Ciro Immobile e Alessio Cerci, ndr). L’azione del secondo gol, però, non è nata lì, ma dal pressing di Meggiorini. Quando il Genoa batte il calcio d’inizio dopo il gol di Ciro, Riccardo si avventa sul portatore di palla e lo costringe a passare frettolosamente a un compagno. Quello che lui ha trasmesso con quel pressing, me lo sono ritrovato io nel momento in cui ho deciso di fare quella scivolata che poi ha dato il “la” alla discesa di Alessio. Ero sicuro di prendere il pallone. La sensazione che ho di quel momento è di controllo, di totale dominio sul terreno di gioco.
Ho dato tutto in campo per i compagni, è questa la mia caratteristica. Pur con tutti i miei limiti.