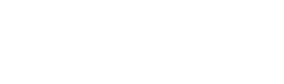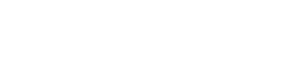Nei miei primi anni di professionismo tra vecchia serie C e campionato cadetto ero molto autocritico riguardo le prestazioni domenicali che fornivo. Probabilmente le esperienze dei due anni antecedenti al primo e concreto approccio lavorativo (Viterbese, 2003-2004) avevano intaccato l’autostima consolidata col trascorrere degli anni abbassandola a deleteri minimi. E così le delusioni e false aspettative avevano via via sgretolato sicurezze e costruito nella mia coscienza un impianto di giudizio molto duro, con il quale mi sarei dovuto confrontare per diversi anni. Allenamenti e prestazioni domenicali sarebbero passati sotto una lente d’ingrandimento che ingigantiva errori analizzati nel dettaglio da un'unica irremovibile prospettiva. Solo attraverso il tempo e l’esperienza accumulata, il giudice interno avrebbe allentato il metro rigido sulle performance, sarebbe diventato più flessibile nell’analisi e mi avrebbe consentito di valutare con maggiore obiettività ed equilibrio il mio agire cogliendo aspetti positivi anche in situazioni che nei primi tempi riteneva non memorabili. Ma a 20 anni convivere con il me stesso critico non era facile. Ricordo con chiarezza i giudizi che formulavo: pessimo, non bene, hai sbagliato quel passaggio, non era quello il posto dove dovevi stare. Focalizzato sempre sugli errori, avevo sviluppato la tendenza di ri(av)volgermi ad essi, tentando, nei limiti delle mie conoscenze di allenamento mentale autocostruito, di cercare nel gesto immaginario visualizzato una alternativa migliore. Quel passaggio di piatto all’esterno, dovevi dosarlo con più forza, più preciso. E se vuoi passare piano il pallone, allora indirizzalo sul suo piede destro, non sul sinistro. Quando rivedevo il film della mia partita percepita, c’era dunque spazio solo per le cose meno belle: dovevo fare meglio, in quel caso era meglio se, non puoi commettere un errore così, lì dovevi coprire lo spazio. E anche se in certe situazioni l’errore non era mio, mi ponevo sempre nella condizione di interrogarmi sul mio operato nei confronti del mio compagno di squadra. Ho fatto il possibile per lui? Ricordo ad esempio un rinvio a spazzare l’area a pochi secondi dalla fine di un match: la palla giunge lontana, distante dai pericoli, eppure subimmo gol dopo una ventina di secondi. Pensai: perché buttarla così, ho sprecato un pallone, avevo Giorgio lì a 10 metri, se la davo a lui potevamo uscire palla al piede e gestire gli ultimi secondi prima del triplice fischio. Ero estremamente fermo nelle mie convinzioni: non potevo sbagliare nulla e ogni partita o allenamento dovevano essere privi di qualsiasi disattenzione o tentennamento. Questa visione rivolta “dentro” e fiscale nella sua quasi asfissiante ripetitività di analisi ha favorito le prime fasi della mia crescita calcistica. Lo stile attentivo era rivolto in grande percentuale ai pensieri, idee e che brulicavano in testa durante l’attività fisica e non solo: tenevo in netta considerazione la partita percepita all’interno senza dare importanza a ciò che avveniva fuori. E la mia partita interna era sviluppata su un binario unico di inesperienza, concentrazione e poche certezze che costituivano la struttura base con la quale valutavo ogni singola azione di gioco. Se da un lato i parametri utilizzati mi imponevano di essere rigoroso e pignolo lasciando poco spazio alla soddisfazione per una discreta prestazione, dall’altro non avvicinavano minimamente il sottoscritto ad una comprensione ampia della realtà: a volte la valutazione soggettiva entrava in netto contrasto con giudizi esterni, come ad esempio quelli dei giornali a cui spesso i calciatori fanno riferimento. Capitava quindi di trovarmi davanti a feedback positivi a cui non davo granché peso e dai quali, come reazione semiautomatica, ne prendevo le distanze; non nascondo che di tanto in tanto mi facevo trascinare da piccole soddisfazioni che sfioravano la mia consapevolezza (bravo Alessandro sei stato il migliore in campo o magari tu hai le potenzialità per giocare in serie B se non in serie A) ma temevo sempre che contenessero dosi esagerate di euforia alla quale era facile abbandonarsi. In realtà non volevo mai essere pienamente soddisfatto di me stesso; perciò capitava che le migliori prestazioni dovevano coincidere con una partita assolutamente perfetta sotto tutti gli aspetti, da quello tattico a quello tecnico, nella quale sbagliavo sì e no 1 passaggio, e dove tutto riusciva al meglio. Scrollarsi di dosso i parametri minimi che mi ero imposto per valutazioni al di sopra della sufficienza soggettiva non è stato facile. Ma forse, per la mia crescita individuale e per il carattere che ho è stato il naturale inizio di un atteggiamento mentale che ho dovuto ricostruire da zero avendo scavato un buco nel quale stavo per seppellire la mia autostima.