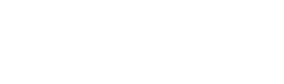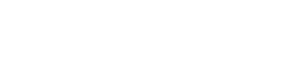Ricordi adolescenziali...
Riflettendo di tanto in tanto sui miei primi passi con il pallone tra i piedi, mi imbatto spesso in un episodio spartiacque che ha capovolto la mia visione delle cose, invertito il mio modo di intendere la partita e influenzato precocemente il mio stile di gioco. Lo affermo con obiettiva lucidità visto e considerato che nel corso del tempo tale episodio ha acquisito, nella mia mente, sempre più maggior rilevanza e lo ritengo uno degli snodi emotivi che hanno impresso alla mia giovane coscienza una direzione netta e in controtendenza rispetto all’ evoluzione tecnico tattica che stavo sviluppando. E nonostante mi sia impossibile stabilire con assoluta certezza il confine che differenzia una decisione consapevole da una che al contrario viene imposta dai limiti fisici che uno si ritrova, non ho particolari dubbi nel ritenere la “svolta” intrapresa verso i 12 anni come scelta cosciente. Si è rivelata la mia fortuna. Tant’ è che senza quel taglio netto con le mie prime uscite sui campi della Valbelluna, probabilmente non sarei riuscito a realizzarmi nel ruolo in cui ho svolto la totalità delle partite da professionista ovvero quello di centrocampista centrale dalla spiccata vocazione difensiva. Il salto mentale intrapreso avviene quindi prima dello sviluppo fisico che mi ha dotato di ottima forza e discrete capacità aerobiche, caratteristiche che nel periodo preadolescenziale non erano ancora prevedibili. Sta di fatto che la svolta di cui parlo avviene proprio nel suddetto periodo in una tersa mattinata di una domenica di metà aprile. Nella mia testa cambiò tutto. A quel tempo avevo appena compiuto 13 anni e giocavo nell’ U.s. Plavis la società del mio paese, Santa Giustina. Ero stato aggregato per necessità alla squadra dei nati nell’ 83/84 della quale dal punto di vista anagrafico avrei dovuto far parte: utilizzo il condizionale perché già dall’ anno precedente per indubbie qualità tecniche superiori circoscritte al contesto comunale ero stato inserito nella squadra giovanissimi 81/82. Ero un attaccante di qualità per la categoria, sfoderavo dribbling e discese palla al piede, cross ben calibrati e frequentemente andavo in gol; il mio interesse per la tecnica individuale era tutto concentrato in una videocassetta che mio padre (allenatore delle squadre inferiori) custodiva a casa: 3 ore di filmati con esercitazioni tecniche di tutti i tipi per ragazzini della mia età. Guardavo, memorizzavo, provavo e riprovavo per pomeriggi interi tutte quelle mosse, quei movimenti che poi riproponevo in partita da ala sinistra. Far parte di un gruppo dove la totalità degli elementi era più grande di me aveva influito sul mio carattere: non mi atteggiavo da primo della classe, l’ agonismo e la competitività venivano soddisfatti e di conseguenza mi divertivo di più, cosa che nell’ altro caso non avveniva e mi rendeva spesso egoista, svogliato e con la presunzione di essere una spanna sopra a tutti. Perciò quella domenica mattina non ero granchè entusiasta di giocare con i pari età, lo devo ammettere, ma piccole e impercettibili variabili resero la giornata memorabile. Perché lo svantaggio di un gol al termine dei primi 30 noiosi minuti nei quali farfugliavo di tanto in tanto moderate imprecazioni tipiche di colui che sa di essere più forte, mi fece entrare in spogliatoio alla ricerca di un qualsiasi lume. Per l’ennesima volta sentivo in quella situazione la tremenda sensazione di una perdita di tempo; i tuoi compagni non sono all’ altezza, non ti servono nella maniera corretta e bla bla bla, le solite stronzate di un pretenzioso viziato. Ci pensò l’allenatore, ex portiere della prima squadra, a rigirare la chimica dei miei pensieri: un uomo alto e possente dal carattere bonario e contadino, che stilava in dialetto locale con qualche accento di italiano grezzo, tipiche chicche di concretezza montanara. Mentre rimuginavo alle poche e isolate possibilità del primo tempo le parole che “Micio” proferì in spogliatoio si scolpirono in qualche sconosciuto marmo della mia psiche: parlò di squadra, di spirito di sacrificio, di lottare insieme di fronte alle difficoltà. Non che avessi mai sentito quei discorsi in altre occasioni ma per la prima volta in quelle espressioni tanto semplici quanto vere, denotavo sfumature che al mio ego sembrarono illuminanti al pari di una rivoluzione copernicana. Mi sentii la persona più responsabile del risultato della prima frazione di gioco e l’unica cosa che dovevo fare, o meglio imparare a fare, era cestinare le mie ambizioni individualistiche per mettermi a disposizione totale dei miei compagni di gioco. Mi ripetevo dentro che loro avevano bisogno di me, che loro contavano su di me e che io avrei dovuto, in un modo diverso dal solito, giocare per loro. Per la prima volta in una partita di calcio mettevo solo loro davanti a me. Mettevo la squadra davanti alle mie velleità tecniche. Mettevo davanti il noi all’ io. Quindi entrai in campo decidendo di fare ciò che prima non avevo mai fatto: correre per gli altri, giocare per loro. Non fu tanto l’assist o il gol realizzato, le palle recuperate o gli interventi in scivolata. Fu l’emozione che provai per tutto il secondo tempo a marchiare a fuoco una partita tra ragazzini che è diventata una delle prove più esaltanti della mia vita. Un’ eccitazione che prima non avevo mai percepito e che da quel momento in poi dava una linfa diversa allo sforzo che producevo sul terreno di gioco. Linfa di colore blu. Bastarono dunque quei 30 minuti a sfiorare le giuste corde emotive e indirizzare la mia crescita su binari mentali ben diversi da quelli su cui stavo viaggiando: nei due anni successivi non tra poche difficoltà di varia natura cambiai ruolo in campo trovando nella zona mediana del rettangolo verde l’habitat ideale nel quale esprimere parte della mia personalità e della mia “filosofia” di gioco.
“Oggi Alessandro ha giocato per gli altri”, disse Micio a mio padre al termine dell’incontro.