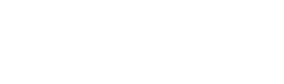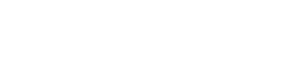Sembrava un fruscio ovattato...
Una sinusoide ondulata e armonica, che in un breve lasso di tempo si infiltrava a far vibrare le piccole ossa del mio organo sensoriale. Un beat, una gamma continua e subliminale. Lo sentivo, certo. Situato su una frequenza minore del mio spettro percettivo, quel suono faceva vibrare la mia anima di serenità. Il gol scuoteva dolcemente la rete, e io gioivo. Solo. Pura estasi, ridotta a un tiro immaginato nella porta dei miei sogni. Nell’angusto salotto di casa. Verso il tardo pomeriggio, prima di cena, recuperavo gli elementi essenziali: una paletta con manico, due mollette stendipanni, un lenzuolo consumato, una scatola in plastica da mercato, una scatola delle scarpe, due scarpe. Disegnavo dentro di me gli spigoli bianchi della porta di uno stadio: gli angoli retti aderivano perfettamente alla sbilenca costruzione che occupava il centro del soggiorno. La porta reggeva, nonostante l’architettura improvvisata: prendevo una pallina da tennis in spugna blu, morbida e ruvida, e dal corridoio iniziavo a calciare verso la porta. Facevo un tocco, due tocchi e calciavo in tutti i modi, di sinistro di destro in scivolata al volo, di tacco. Calciavo e calciavo: facevo un uno-due con l’ingresso di casa, con il muro, immaginavo avversari, immaginavo il portiere, uscivo e rientravo in quel sogno che si sovrapponeva al salotto e allo stadio delirante del mio subconscio. Calciavo da solo mentre mamma cucinava e papà si riposava. Calciavo e calciavo. Rebecca era sul divano con le bambole, anche lei rivolta al suo mondo interiore. Io intanto colpivo la palla di collo, collo interno, esterno, punta, tacco e con tutte le parti sconosciute del piede sinistro. Calciavo e calciavo. La gente applaudiva, i tifosi cantavano. Sentivo la pallina deformarsi al contatto con il piede, come se uno slow motion temporaneo mi inchiodasse al piacere della fusione fugace di pelle e spugna. E apprendevo, al contatto, la differenza tra le superfici del mio piede, che esploravo come un astronauta in una galassia lontana. Calciavo e calciavo in quella porta azzardata, tiravo dentro, fuori, dentro e ancora dentro. Dribblavo ostacoli inesistenti. Calciavo in una e nell’altra dimensione, all’incrocio o all’angolino. Centrale, sulla destra e alla sinistra. E ogni volta che centravo la porta e il pallone oltrepassava la mia linea invisibile, il lenzuolo che faceva da rete vibrava. Mi sembrava tutto mistico, il gol mi procurava un brivido che si espandeva anche sul lenzuolo usato: galleggiava nell’aria, fluttuava in pieghe dalle linee dolci, che rimanevano impresse nel mio quadro dopaminico. Scansionavo ogni piccola deformazione della rete, ogni tratto alterato, anche quello meno appariscente. Esultavo sottovoce tra le urla gioiose dei tifosi mentre il televisore proiettava un telegiornale e la mia mente sfarfallava confusa in diapositive rossonere riflesse da una fantasia di ordine superiore. E poi, come insoddisfatto dal protrarsi di una gioia ormai svanita, ritornavo a calciare. Perdersi in quei quindici, venti minuti prima di cena. Poi, dopo, avevo la possibilità di giocare il derby contro l’Inter: papà a difendere la mia porta dei sogni, e io davanti alla sedia in corridoio. Ma quella era un'altra dimensione.