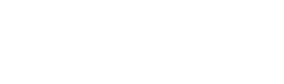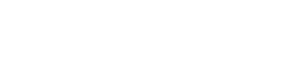Un disagio domenicale...
E’ una prigione temporanea, un rifugio, un cesso. Fra qualche minuto uscirò da qui, ma preferirei starci dentro ore, giorni. Nella claustrofobica sicurezza del bagno della camera di questo hotel a quattro stelle. Il marmo decorato, un lavandino pulito e 3 rotoli di carta igienica. Due saponette e un tubetto di scadente bodylotion. Il mio beauty è ancora lì a fianco delle prese di corrente poste al lato dello specchio. La luce della lampadina emana una fredda atmosfera, molto fredda. C’è un sentore di fragranza che sta per svanire. Fuori, nella camera, sento i titoli del telegiornale, sono su per giù le 12.30 ed io occupo una prigione temporanea, un rifugio, un cesso. Con le mani in faccia, e gli indici che coprono le palpebre. Perché me ne sto qui a inanellare secondi come se fossero i rimasugli di un tempo che sta per schiantarsi contro l’inevitabile partita a cui devo andare incontro? Perché ho ansia? Penso. Per quale motivo, dopo tante apparizioni nella massima serie ripiombo a percepire le sensazioni che sembravano ormai dimenticate nel tenebroso oscuro messo da parte? Da dove proviene tutta la mia insicurezza? Le domande avranno pure risposte, ci sarà una soluzione qui da qualche parte, sul marmo del lavandino, sulla ceramica del piatto della doccia, nei tubi degli scarichi, ovunque. Forse sullo specchio: sì, forse se apro gli occhi e scruto con attenzione una delle due pupille, forse lì dentro in quel nero magnete sì cela ciò che cerco. Che forse non è poi così complicato e faticoso trovarlo, basta un po' di senso logico: sono fragile, debole, sono quello che sono sempre stato. E non posso competere a un certo livello in queste condizioni psicofisiche. Più che fisiche, psichiche. Non sono quello che pensavo di essere ed ora mi sto abbandonando ad un’inerzia imprevista degli eventi. Spinto da un delicato soffio di vento, il bicchiere sta cadendo non so dove frantumandosi in mille pezzi. Il sopracciglio è aggrottato, la sua curva inclinazione è il riflesso di un’ansia che conosco bene, che ho imparato a gestire, ma che ora si presenta elevata al cubo e che adesso mi imprigiona al corpo incatenato da invisibili paure. Voglio respingerla, non riesco a respingerla. Non basta relativizzare tutto e rapportare la mia condizione di precaria stabilità mentale a ciò che succede ogni secondo in qualsiasi parte del mondo. Cosa sono i veri drammi e tragedie delle sfortunate vite sparse nel pianeta se paragonati a quello che sto vivendo? E di che cosa mi dovrei preoccupare dopotutto? Eppure… C’è qualcosa di incolore che filtra nel mio corpo che di ansia non ne può più. Le gambe somatizzano, troppo. I miei arti sembrano sudare ma non sudano; anche le mani faticano ad essere sciolte. Le sento faticare, sì, anche loro. Mi sento contratto, insicuro nella camminata, ma a chi dire queste cose, se non a me stesso in un flusso circolare e micidiale di pensieri da tenere dentro? Sotto l’epidermide, sento un fibrillare negativo emanato nei polpacci e nei quadricipiti. Sento di non avere forza. Sotto l’epidermide una linfa trasparente sembra scorrere al posto del sangue irrorando tutte le fibre che soggette a tale inattesa sostanza le piega ad un volere biologico sconosciuto. Le fibre sembrano sciogliersi, dentro. Non è per niente piacevole. L’ansia è trasparenza interna, trasparenza esterna. Dovrò giocare oggi, in qualche modo e so bene che il campo non mente. Lì, sul verde soffice. Gli spettatori non sanno quello che a volte succede dentro di te. Forse lo immaginano ma non sanno che cosa si prova a giocare quando per un motivo che neanche tu conosci hai la paura fottuta di stoppare la palla e di commettere anche uno stupido errore. Uno stop, cazzo, un semplice stop diventa un gesto pesante dall’elevata fatica cerebrale. Lì, davanti a tutti, che ti fissano in tutta la tua inadeguatezza. Perché in certi momenti ti senti inadeguato all’ambiente. E perché di nuovo mi faccio trascinare da tali pensieri qui nel cesso della camera di un hotel a 4 stelle diventato opprimente via di fuga? Il diaframma: parte tutto da lì, dalla “pancia profonda” che riconosco come centro nevralgico di emozioni non consone per preparare un match di serie A. Sento che non ci sono. Cazzo. Non ci siamo Alessandro, non ci siamo! Non ci siamoooo! Mi concentro cercando di ripassare i movimenti e gli schemi da svolgere, ma niente. Fatico ad essere presente e so già che mentre giocherò la tentazione di girarmi verso i tabelloni elettronici a bordo campo prenderà il sopravvento; dopo pochi minuti, io mi volterò e inizierò il mio personale e lentissimo conto alla rovescia e non vedrò l’ora che la partita finisca. Non girarti e non guardare, non girarti e non guardare. L’ansia. Sto cercando in tutti modi di estirpare questa “cosa”, ma non ci riesco. Non resta che tenersela e sperare che se ne vada via e mi lasci in pace. Servirebbe una chiave ma ora di chiavi ne vedo solo una: quella della porta che chiude la serratura del cesso e che mi costringe ad una libertà sofferta. Dovrò entrare in campo. Dai Ale, non avere paura. Andrà via questa “cosa”, Dai Ale dai fatti coraggio. Andrà via questa “cosa”. Dai Ale, fatti coraggio. Cerca di non pensarci. Ci pensi, ma cerca di non pensarci, Dai Ale fatti coraggio. Andrà via questa “cosa”. Dai Ale fatti coraggio. Andrà via questa cosa. Dai Ale fatti coraggio.