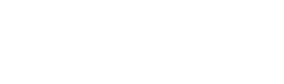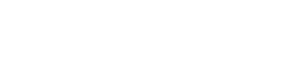Al San Mames di Bilbao...
Ci sono. Sono vivo. Sento la sottomaglia appiccicarsi alla pelle umida, le fibre elastiche unirsi all’epidermide e il sudore diventare collante naturale che suggella uno stato di prontezza quasi assoluto. Sento i pantaloncini che sfiorano la pelle delle cosce. L’aria, nemmeno poi così fredda, che ossigena l’irresistibile desiderio di farla finita con l’attesa e di iniziare la partita, ma ancora non è il momento, no non è ancora il momento. Sento il rivestimento in gomma dei parastinchi aderire alle gambe sotto le strette calze che le coprono fino alle ginocchia. E il peso del mio corpo che si appoggia ai tacchetti in ferro delle mie scarpe. Abbasso lo sguardo: il colore rosso, lucido, vira in ogni direzione, pavimento pareti, soffitti. Il rosso cola nelle pupille prima le bagna poi le inonda. Sembra di essere contenuti in una scatola monocolore nella quale si intravedono da uno spiraglio poco distante le luci esterne dello stadio. Venti metri mi separano dal manto erboso; lì fuori una pioggia fitta e delicata si appoggia all’erba appesantita da ore di maltempo. Non è ancora il momento. Attendo in ordine dietro alcuni miei compagni il segnale dell’arbitro per l’entrata in campo. Due file di tubi inermi luccicanti in acciaio dividono l’ampio corridoio in 3 corsie: al centro gli arbitri, a sinistra la squadra locale, a destra gli ospiti. Sono presente. Con tutto me stesso. E la fusione con l’ambiente è solo il riflesso ultimo del mio concreto sforzo nell’essere sempre più qui e ora; sempre di più. Come a voler espandere un attimo ed immergermi dentro. L’allenamento mentale di questi mesi mi sta aprendo in due, tutto ciò che accadrà sarà esplorazione, sarà esperienza estrema, contatto. La scorsa settimana ho spostato la consapevolezza oltre limiti vertiginosi, la forza energica però non ha retto sui 90 minuti. Chissà stasera cosa accadrà. Giunge il momento. Gli arbitri si avviano, rimango sulla mia fila e osservo dall’altra parte i miei avversari; li vedo lì dietro la verticalità seriale dei tubi amorfi che mi separano da loro: vedo la testa pelata di Mikel Rico, la struttura fisica di San Josè il capello lungo di Benat; non sapevo della loro esistenza fino a qualche settimana fa ed ora me li ritrovo nel giro di sette giorni a doverli affrontare in un sedicesimo di finale di Europa League. È nell’istante in cui mi avvio per l’entrata in campo e guardo le loro maglie a righe biancorosse che accolgo nella mia consapevolezza la luce flebile di un pensiero. Sublime. “Ora uscirò con loro. Andrò a giocare e mi divertirò come con gli amici su un prato di campagna”. Mi emoziono: perché tale concetto non nasce da una distrazione superficiale colta per allentare la pressione pregara; si origina da una dimensione più profonda, viscerale. Sembra risalire dal centro del corpo. Lo sento dentro il “concetto”, lo accolgo, me lo ripeto 1, 2, 3 volte. Mi pervade una gioia malinconica, come se avessi ritrovato dopo decenni il senso di una sfida pura dove esiste, solo ed incontaminato, il piacere di una nuova scoperta. Aver ritrovato ciò significa veramente aver ritrovato me stesso. Bambino. Era tutto quello che volevo. Che brivido diomio. Portatelo dentro per tutta la vita. Cammino dietro Omar. Il rosso del tunnel comincia a svanire e si delinea l’ambiente di gioco. Esco all’aria aperta. La pioggia è delicata. Lo stadio esaurito si rivela. I tacchetti affondano nel verde del San Mames.