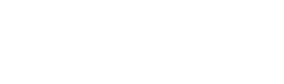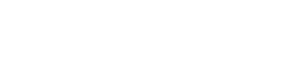E alla fine Guardiola ce l’ha fatta. Dopo sette anni di lavoro, di investimenti societari sostanziosi e di continuità progettuale che il resto del panorama calcistico europeo sogna, il catalano è riuscito a portare all’ altra sponda di Manchester quel trofeo che per il City era diventato già da diverso tempo l’obiettivo principale. Lo ha fatto meno brillantemente di quanto ci si aspettava. Ma d’altronde per vincere a volte basta solo un pò di efficacia e di sana fortuna senza dover erigere strutture di gioco sognanti. Parlo di sana fortuna perché a rigor di logica, dopo aver riavvolto il percorso mastodontico fatto durante la stagione e dopo diversi tentativi per accaparrarsi il prezioso trofeo (non ultimo la finale di Champions di due anni fa) l’equilibrio invisibile che regola “un mondo”, e in questo caso quello di Pep, in ultima analisi mette a pari gioie e dolori.
Sebbene il capitolo conclusivo di questa Champions League non sia da considerarsi un capolavoro di spettacolarità estetica ci tengo a fare due considerazioni che vanno al di là dell’aspetto tremendamente tattico che appassiona il popolo italiano.
La prima. La difficoltà emotiva del City che, carico di aspettative e favorito dai pronostici, si è visto costretto a interpretare il match con una pressione che l’ Inter non ha nemmeno lontanamente percepito, assottigliando quel divario che tutti gli spettatori immaginavano. Era già successo due anni fa contro il Chelsea e ieri sera questa ansia da risultato si è palesata nuovamente contro la squadra nerazzurra. Ma forse, non è granchè corretto parlare d’ansia: ho visto, in certi momenti, una sorta di paura sportiva che andava oltre la mera preoccupazione fisiologica. A tratti annusavo dalle immagini televisive un “terrore” sportivo di cui Stones (forse quello che apparentemente ha vissuto meglio la partita) e compagni ne erano quasi preda, incapaci di realizzare quelle geometrie estetiche a cui ci avevano abituato. C’era da aspettarselo. D’altronde i team di Guardiola assumono per default la nomea di favorite influenzando non poco le aspettative sui risultati finali. Del peso emotivo che i giocatori in campo sono stati costretti a sopportare ne sa qualcosa il belga De Bruyne, esempio lampante della “fragilità” del proprio fisico di fronte a sfide dal peso psicologico enorme, che dopo il trauma cranico di due anni fa contro la squadra di Tuchel, ha dovuto abbandonare nuovamente il terreno di gioco, stavolta per un infortunio muscolare. I Citizens infatti hanno sentito fin da subito non tanto l’importanza dell’evento quanto l’importanza di essere costretti a vincere la Champions (a tal proposito: quanta pressione inconscia ha scaricato Guardiola sui suoi? Quanto sentiva Guardiola la pressione che incombeva su se stesso?). Un secondo fallimento sarebbe stata un amarezza troppo grande da digerire. Quindi squadra meno brillante, meno spettacolare, tesa fino al midollo e molto più preoccupata del rischio elevato di sconfitta al minimo errore. E di errori, ieri, se ne sono visti diversi, decisamente clamorosi se così si può dire. Le giuste armonie del gioco guardiolano che siamo abituati a vedere hanno assunto connotazioni rallentate, imperfette. Disturbate. Molto disturbate. Ma alla fine, efficaci.
Il secondo aspetto balzato all’occhio che ha diminuito ancor di più il divario globale tra le due squadre è la confermata solidità dell’approccio tattico italiano, che ha visto nel lavoro di Simone Inzaghi una rinnovata capacità di ostruire prima e costruire poi, mettendo sempre al centro quella cultura squisitamente italica dedita più al risultato e meno al gioco. Senza tra l’altro metter da parte la spettacolarità. Dicono tutti che le cose stanno cambiando: il fatto che nelle tre finali europee ci siano state tre italiane a giocarsela potrebbe essere un segnale di vago risveglio tricolore. Senza ombra di dubbio dal punto di vista tattico il campionato di Serie A si conferma tra i più sofisticati in senso assoluto. Ma purtroppo, essendo il livello tecnico correlato all’andamento finanziario dei club la qualità dei singoli sta perdendo sempre più punti. E questo ieri sera è stato più che visibile. Se la rigidità analitica del sapere italiano ha imbrigliato il Power tiki-taka senza inventare realmente nulla di nuovo, dal punto di vista tecnico la differenza si notava eccome. Dove? Sul grado di pericolosità delle occasioni. Il gol di Rodri, di un’intelligenza automatica fuori dalla norma con palla indirizzata proprio lì sull’angolo tra Darmian e il palo alla sinistra di Onana, ne è la chiara certificazione. E’ vero, Haaland non ha avuto nessuna occasione nitida e in totale si contano si e no 4 tiri in porta del City, ma le occasioni a dir poco clamorose dell’Inter (su tutte quella di un “estraneo” come Di Marco è pazzesca) hanno sancito in maniera netta la supremazia qualitativa degli inglesi. La pericolosità delle occasioni nerazzurre appariva, al momento topico, fiacca e sbilenca, indicando l’insufficienza della propria forza offensiva di fronte alla corazzata inglese. E in questa sorta di tensione elettrostatica quale è stata la finale di ieri sera, ciò che ha fatto realmente la differenza, è stata dunque la qualità del singolo. Di Rodri.
La giocata.
76’ 50”. Il dribbling di Foden su Di Marco.